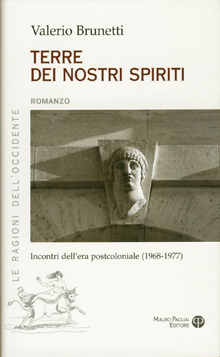Ricerca Veloce
Ricerca Avanzata
chiudi
Oltre il solito stereotipo degli italiani all’estero per fame e disperazione, esce in libreria il racconto di Valerio Brunetti, geometra e globetrotter innamorato dell’Africa
Oltre il solito stereotipo degli italiani all’estero per fame e disperazione, esce in libreria il racconto di Valerio Brunetti, geometra e globetrotter innamorato dell’Africa Quando si pensa all’emigrazione italiana, il pensiero cade di solito sulla dolente memoria di masse diseredate, costrette dal bisogno a lasciare la patria per cercare fortuna in terre straniere. È giusto ricordare, però, che accanto a questo aspetto del fenomeno, i flussi migratori hanno presentato anche aspetti positivi, giustamente ricordati da un grande storico come Gioacchino Volpe nella sua Italia in cammino. La nostra emigrazione è stata un’emigrazione anche di personale qualificato, di imprenditori, di tecnici, di intellettuali, che nelle più diverse parti del pianeta – dall’Egitto all’America Latina – hanno tenuto alto il prestigio del lavoro italiano nel mondo. C’è poi un altro tipo di emigrazione, di cui si parla poco ma che ha contribuito e tuttora contribuisce alla crescita della nostra economia. È quella che si potrebbe definire un’emigrazione part time. È l’esperienza di tecnici, di operai specializzati, di manager che trascorrono tutta o una parte consistente della loro vita lavorando presso aziende impegnate nella realizzazione di grandi opere in tutti i continenti. Questi lavoratori non perdono la residenza in Italia, non abbandonano per sempre la loro terra, sono certo ben più tutelati degli emigranti di un tempo; ma emigranti rimangono, anche se emigranti di lusso, chiamati spesso a vivere in realtà esplosive o degradate del terzo mondo.
Un primo squarcio di luce su questa realtà fu aperto, nel 1979, da Primo Levi, scrittore ma al tempo stesso chimico, con un romanzo, La chiave a stella, dedicato alle vicende di un operaio iperspecializzato, apprezzatissimo da ingegneri e manager, orgoglioso – in un’epoca di diffusa cultura del rifiuto del lavoro manuale – della sua opera nei grandi cantieri di tutto il mondo. Trent’anni dopo è la volta delle memorie di Valerio Brunetti, che ha lavorato dal 1966 al 1977 al seguito delle maggiori imprese impegnate all’estero, in un percorso cominciato in Australia e proseguito in Libia, Pakistan, Nigeria d Eritrea. Più che sugli aspetti tecnici del lavoro, i ricordi di Brunetti, raccolti nel volume Terre dei nostri spiriti (Mauro Pagliai Editore, Firenze 2009, pp. 398, euro 16), si posano sui suoi risvolti culturali, etici, politici. Ne emerge una suggestiva panoramica di testimonianze, di riflessioni, di aneddoti maturati in nove anni e tre continenti.
L’avventura all’estero di Brunetti comincia nel 1968 in Australia. Vagamondo per vocazione e déraciné per trauma familiare, perito industriale e geometra, il venticinquenne Valerio ha un padre latitante dall’immediato dopoguerra, una madre campionessa di pattinaggio acrobatico, uno zio combattente a Giarabub agli ordini dell’eroico colonnello Castagna e una zia, Beatrice Mancini, attrice cinematografica negli anni Trenta (recitò anche in Luciano Serra Pilota) rimasta fuori dal giro a soli trent’anni per i trascorsi fascisti. Anche per questo spera di rifarsi una vita in Australia, un continente ricco di prospettive in cui la comunità italiana è stimata e apprezzata e non esistono episodi di corruzione («l’italiano – osserva giustamente, - posto in un ambiente sano e onesto, resta sano e onesto con il merito di aggiungere quel pizzico di genialità che l’ha sempre distinto»). Impiegato in un’azienda multinazionale, spera di radicarsi nel continente e chiama presso di sé la madre; ma questa, dopo una storia d’amore con un politico locale conosciuto durante la traversata, preferisce tornare in Italia lasciandolo solo con la casa già arredata e spingendolo ad abbandonare l’Australia. La sua avventura di tecnico all’estero proseguirà qualche mese dopo, nel gennaio del 1969, in una Libia in cui, dopo la guerra dei Sei Giorni, che ha rinfocolato il nazionalismo arabo, il benevolo regno di re Idris e la pacifica convivenza fra italiani e locali sono minati dalla propaganda antioccidentale che porterà pochi mesi dopo al golpe di Gheddafi. Ma la sua permanenza è breve, perché la scoperta della truffa posta posta in atto dalla ditta per cui lavora (ributtare in mare la rena dragata, per aumentare i costi di lavoro in un’eterna tela di Penelope), lo induce a tornare in Italia. In Libia rientrerà nel 1973, in tempo per rimanere testimone del burrascoso arrivo all’aeroporto di Tripoli di un jet dirottato dai terroristi di Settembre Nero. Ma prima avrà modo di sperimentare i prodromi del fondamentalismo islamico in Pakistan, facendo fra l’altro conoscenza della barbarica pratica dell’infibulazione.
L’approccio di Brunetti alla realtà con cui viene a conoscenza si può considerare a-ideologico. L’autore non parte dal partito preso, politico o religioso (manifesta, per esempio, molta stima per la religione islamica), ma si fonda o sulla diretta conoscenza dei fatti, o su testimonianze di prima mano, in certi casi sconvolgenti. Dalle parole del nostro console a Tripoli, conosciuto nel 1969, un italo-libico di nome Selim Kattam, Brunetti apprese per esempio che gli italiani erano ancora «apprezzati dagli anziani, da coloro che conobbero tempi migliori, a cui fu data un’istruzione e un lavoro»; e, sempre in Libia, s’imbatté in un sottufficiale che aveva servito nel Regio Esercito e che avrebbe dato «il braccio destro per tornare al tempo degli italiani». Da un collega scozzese apprese, nel 1973, che secondo i servizi segreti britannici Nasser sarebbe morto avvelenato bevendo in un bicchiere destinato al re di Giordania, e dallo stesso collega si sentì dire che, se la Libia avesse voluto i danni di guerra dall’Italia, avrebbe dovuto per prima «ripagare tutto quello che gli italiani hanno costruito nei trent’anni di occupazione».
Le emozioni più struggenti sono tuttavia suscitate in Brunetti dal soggiorno in Eritrea, la terra da cui il suo vecchio insegnante di scuola elementare, il maestro Barbieri, era partito esule ancora bambino durante la seconda guerra mondiale e che, pur avendo perso tutto con la caduta dell’Impero, «usava parole di stima per il Negus Neghesti, il Re dei Re Hailè Selassiè, quell’uomo minuto che gli inglesi a malapena sopportarono nel suo esilio in Gran Bretagna, ma che dall’alto della sua straordinaria statura morale aveva salvato la vita a migliaia di prigionieri, sia italiani sia eritrei, dalla possibile e terribile rappresaglia etiope seguita alla sconfitta militare». Ma il soggiorno in Eritrea costituisce per l’autore anche l’occasione per fare conoscenza con la figura di uno dei grandi eroi della conquista dell’Etiopia e della seconda guerra mondiale: il colonnello Lorenzini, il “capo dalla folta barba” idolatrato dagli ascari, convinti che, se egli fosse morto, anche l’impero italiano nella regione sarebbe caduto con lui. Purtroppo, così avvenne: «costernate, le truppe indigene indietreggiarono impaurite, l’ombra della disfatta diventò realtà, anche fra le truppe italiane» e dopo pochi giorni capitolò anche Cheren. Lorenzini, nominato generale sul campo prima di morire, aveva firmato col suo sangue una delle pagine ultime e più gloriose nella storia dell’Italia imperiale.
Un primo squarcio di luce su questa realtà fu aperto, nel 1979, da Primo Levi, scrittore ma al tempo stesso chimico, con un romanzo, La chiave a stella, dedicato alle vicende di un operaio iperspecializzato, apprezzatissimo da ingegneri e manager, orgoglioso – in un’epoca di diffusa cultura del rifiuto del lavoro manuale – della sua opera nei grandi cantieri di tutto il mondo. Trent’anni dopo è la volta delle memorie di Valerio Brunetti, che ha lavorato dal 1966 al 1977 al seguito delle maggiori imprese impegnate all’estero, in un percorso cominciato in Australia e proseguito in Libia, Pakistan, Nigeria d Eritrea. Più che sugli aspetti tecnici del lavoro, i ricordi di Brunetti, raccolti nel volume Terre dei nostri spiriti (Mauro Pagliai Editore, Firenze 2009, pp. 398, euro 16), si posano sui suoi risvolti culturali, etici, politici. Ne emerge una suggestiva panoramica di testimonianze, di riflessioni, di aneddoti maturati in nove anni e tre continenti.
L’avventura all’estero di Brunetti comincia nel 1968 in Australia. Vagamondo per vocazione e déraciné per trauma familiare, perito industriale e geometra, il venticinquenne Valerio ha un padre latitante dall’immediato dopoguerra, una madre campionessa di pattinaggio acrobatico, uno zio combattente a Giarabub agli ordini dell’eroico colonnello Castagna e una zia, Beatrice Mancini, attrice cinematografica negli anni Trenta (recitò anche in Luciano Serra Pilota) rimasta fuori dal giro a soli trent’anni per i trascorsi fascisti. Anche per questo spera di rifarsi una vita in Australia, un continente ricco di prospettive in cui la comunità italiana è stimata e apprezzata e non esistono episodi di corruzione («l’italiano – osserva giustamente, - posto in un ambiente sano e onesto, resta sano e onesto con il merito di aggiungere quel pizzico di genialità che l’ha sempre distinto»). Impiegato in un’azienda multinazionale, spera di radicarsi nel continente e chiama presso di sé la madre; ma questa, dopo una storia d’amore con un politico locale conosciuto durante la traversata, preferisce tornare in Italia lasciandolo solo con la casa già arredata e spingendolo ad abbandonare l’Australia. La sua avventura di tecnico all’estero proseguirà qualche mese dopo, nel gennaio del 1969, in una Libia in cui, dopo la guerra dei Sei Giorni, che ha rinfocolato il nazionalismo arabo, il benevolo regno di re Idris e la pacifica convivenza fra italiani e locali sono minati dalla propaganda antioccidentale che porterà pochi mesi dopo al golpe di Gheddafi. Ma la sua permanenza è breve, perché la scoperta della truffa posta posta in atto dalla ditta per cui lavora (ributtare in mare la rena dragata, per aumentare i costi di lavoro in un’eterna tela di Penelope), lo induce a tornare in Italia. In Libia rientrerà nel 1973, in tempo per rimanere testimone del burrascoso arrivo all’aeroporto di Tripoli di un jet dirottato dai terroristi di Settembre Nero. Ma prima avrà modo di sperimentare i prodromi del fondamentalismo islamico in Pakistan, facendo fra l’altro conoscenza della barbarica pratica dell’infibulazione.
L’approccio di Brunetti alla realtà con cui viene a conoscenza si può considerare a-ideologico. L’autore non parte dal partito preso, politico o religioso (manifesta, per esempio, molta stima per la religione islamica), ma si fonda o sulla diretta conoscenza dei fatti, o su testimonianze di prima mano, in certi casi sconvolgenti. Dalle parole del nostro console a Tripoli, conosciuto nel 1969, un italo-libico di nome Selim Kattam, Brunetti apprese per esempio che gli italiani erano ancora «apprezzati dagli anziani, da coloro che conobbero tempi migliori, a cui fu data un’istruzione e un lavoro»; e, sempre in Libia, s’imbatté in un sottufficiale che aveva servito nel Regio Esercito e che avrebbe dato «il braccio destro per tornare al tempo degli italiani». Da un collega scozzese apprese, nel 1973, che secondo i servizi segreti britannici Nasser sarebbe morto avvelenato bevendo in un bicchiere destinato al re di Giordania, e dallo stesso collega si sentì dire che, se la Libia avesse voluto i danni di guerra dall’Italia, avrebbe dovuto per prima «ripagare tutto quello che gli italiani hanno costruito nei trent’anni di occupazione».
Le emozioni più struggenti sono tuttavia suscitate in Brunetti dal soggiorno in Eritrea, la terra da cui il suo vecchio insegnante di scuola elementare, il maestro Barbieri, era partito esule ancora bambino durante la seconda guerra mondiale e che, pur avendo perso tutto con la caduta dell’Impero, «usava parole di stima per il Negus Neghesti, il Re dei Re Hailè Selassiè, quell’uomo minuto che gli inglesi a malapena sopportarono nel suo esilio in Gran Bretagna, ma che dall’alto della sua straordinaria statura morale aveva salvato la vita a migliaia di prigionieri, sia italiani sia eritrei, dalla possibile e terribile rappresaglia etiope seguita alla sconfitta militare». Ma il soggiorno in Eritrea costituisce per l’autore anche l’occasione per fare conoscenza con la figura di uno dei grandi eroi della conquista dell’Etiopia e della seconda guerra mondiale: il colonnello Lorenzini, il “capo dalla folta barba” idolatrato dagli ascari, convinti che, se egli fosse morto, anche l’impero italiano nella regione sarebbe caduto con lui. Purtroppo, così avvenne: «costernate, le truppe indigene indietreggiarono impaurite, l’ombra della disfatta diventò realtà, anche fra le truppe italiane» e dopo pochi giorni capitolò anche Cheren. Lorenzini, nominato generale sul campo prima di morire, aveva firmato col suo sangue una delle pagine ultime e più gloriose nella storia dell’Italia imperiale.
Data recensione: 09/10/2009
Testata Giornalistica: Il Secolo d’Italia
Autore: Enrico Nistri